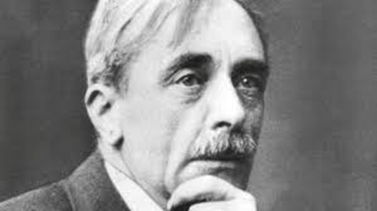La nostra intelligenza è a rischio?
UNA RIFLESSIONE VECCHIA, EPPURE PIÙ CHE MAI PERTINENTE:
“Le Bilan de l’intelligence” è il titolo di una conferenza di Paul Valéry, tenuta il 16 gennaio 1935 all’Université des Annales.
Ottantasette anni fa, il poeta francese rifletteva sull’evoluzione dell’intelligenza umana. Si preoccupava degli effetti negativi del progresso tecnologico sul nostro intelletto. Notava angosciato che se, da un lato, la rivoluzione industriale aveva accresciuto il benessere materiale, dall’altro aveva impigrito la mente, diminuito il senso critico e indebolito la sensibilità.
Da una parte, la mente è sublime quando scopre la corrente elettrica o i raggi X e ne trae applicazioni pratiche straordinarie (dal telegrafo fino alla televisione…) ma dall’altra è miserabile quando, dopo aver inventato strumenti nuovi, ne promuove la vendita istillando di sana pianta finti bisogni. Si diffonde così un’“intossicazione insidiosa” che ha per unico scopo quello di lucrare.
Le nuove tecnologie assoggettano l’uomo a dei ritmi accelerati innaturali e lo portano a percepire il tempo in modo diametralmente opposto a come lo percepiva prima della rivoluzione industriale. Le parole d’ordine sono diventate “fretta” e “velocità”. “Non sopportiamo più la durata” e “non sappiamo più fecondare la noia”. L’uomo contemporaneo ha perso il senso di continuità e di deferenza verso il passato: “Non guardiamo più il passato come un figlio guarda suo padre, e dal quale può imparare qualcosa, ma come un uomo fatto guarda un bambino.” Valéry mette in evidenza una discrepanza nitida fra due velocità: l’andatura frenetica del progresso scientifico mal si accozza con il passo dell’uomo sottoposto per natura, in quanto essere vivente, a tempi biologici lenti. L’essere umano è costretto a adeguarsi a bruschi e improvvisi cambiamenti mai incontrati prima. “Siamo, ogni giorno, alla mercé di un’invenzione, di un accidente, materiale o intellettuale”. Siamo giunti al punto in cui le creazioni nate dalla nostra intelligenza sorpassano e danneggiano la nostra intelligenza stessa. “Tutto quello che sappiamo, vale a dire tutto quello che possiamo, è arrivato ad opporsi a ciò che siamo.”
Di fronte all’accelerazione degli scambi, alla spettacolarizzazione degli eventi, agli eccessi in generale, al consumismo, Paul Valéry teme un istupidimento, teme che l’umanità ritorni a “uno stato istintivo” e riscenda “all’incostanza e alla futilità della scimmia”. Sottolinea il notevole aumento di insonnie legato allo stato di continua irrequietezza che l’era tecnologica determina. Deplora l’inadeguatezza dell’insegnamento scolastico che privilegia lo studio di argomenti squisitamente nazionali invece di allargare l’investigazione a scala internazionale. In un mondo che si trasforma a grande velocità, per capire i fenomeni e le loro implicazioni, è imperativo portare uno sguardo sulla totalità del pianeta. Denuncia un’istruzione che si concentra sull’importanza del diploma e non si cura affatto della formazione di menti indipendenti e agguerrite. “Il diploma dà alla società un fantasma di garanzia, e ai diplomati fantasmi di diritti.” Quando l’oggetto dello studio è l’ottenimento di un diploma, entra in moto un meccanismo perverso che punta su una preparazione strategica per conquistare l’attestato e non su una preparazione di fondo per acquisire basi solide. “Ne risulta che, in questa cultura adulterata, più niente può aiutare o convenire alla vita di una mente che si sviluppa”.
Teniamo inoltre ben presente di non essere educati solo dalla Scuola: “Per tutta la vita, il nostro ambiente è il nostro educatore”. In ogni momento della nostra esistenza riceviamo lezioni da avvenimenti personali diretti, “les leçons de choses”, e lezioni dalle nostre letture o da bocche altrui. Fra questi due generi di lezioni, le più preziose sono le prime, les leçons de choses, ossia quelle che derivano dalla nostra esperienza personale perché sono i fatti osservati da noi o subiti direttamente sulla nostra pelle che ci danno la spinta a sviluppare il nostro linguaggio. Per rievocare le nostre esperienze, usiamo parole nostre, attingiamo a un serbatoio intimo. Per riflettere su cose che ci sono accadute, siamo stimolati a cercare nuove risorse di vocabolario, a inventare nuove espressioni. Così facendo, sviluppiamo la nostra capacità di pensare. “Una percezione diretta è tanto più preziosa che la sappiamo meno esprimere. Più mette in fallo le risorse del nostro linguaggio, più ci costringe a svilupparle.” Questa affermazione un po’ paradossale di Paul Valéry mi riconduce all’esercizio preconizzato da Rita Levi Montalcini per intrattenere una buona attività cerebrale: scrivere almeno quattro righe giornaliere contenenti un pensiero autobiografico.
Cervello umano Risonanza magnetica con DTI
Le lezioni indirette, quelle che provengono dalle nostre letture o riportate da altri, hanno un valore minore per quanto riguarda la nostra attività intellettiva. Quando riprendiamo a nostro conto formule di cui non siamo “i veri autori”, ci illudiamo di pensare. Sono solo risposte imitative che ci “sciolgono dall’impegno di pensare”. La nostra società fa un uso pletorico e indiscriminato di parole. Cartelloni pubblicitari, volantini, giornali, riviste, messaggi televisivi sovrabbondano e ci sommergono. La pubblicazione di libri non è mai stata così florida; “non si è mai letto tanto, o piuttosto, tanto dato una scorsa alle parole scritte!”. In questa orgia di parole, la qualità non è all’appuntamento: “La nostra sensibilità verbale si è abbrutita, smussata, deteriorata” e “l’inflazione della pubblicità ha fatto scemare al livello più basso la potenza degli aggettivi più forti.” E ora per illustrare il timore di Paul Valéry quanto al destino dell’intelligenza umana, non posso far a meno di tradurre questo breve passaggio che mi sembra molto eloquente e significativo: “ La quantità delle pubblicazioni, la loro frequenza diurna, il flusso delle cose che si stampano o si diffondono, portano via dalla mattina alla sera i giudizi e le impressioni, li mescolano e li impastano, e fanno dei nostri cervelli una sostanza veramente grigia, dove niente dura, niente prevale, e proviamo la strana impressione di monotonia della novità, e di noia delle meraviglie e degli estremi”
Per affrontare la complessa sfida delle modernità, per raggiungere uno stato d’equilibrio, pare dunque fondamentale che l’individuo preservi il suo “tempo libero”. Con questo termine il poeta non si riferisce al “loisir cronometrico” (hobby) esaltato e monetizzato ma bensì al “loisir interiore”, quel momento di distensione, gratuito e staccato dagli orologi che consente alla mente di liberarsi. Si tratta di concedersi tempo per fare chiarezza tra i propri pensieri; di ritagliarsi istanti di pace per meditare, per scavare in profondità nell’intimità del proprio essere. È necessario praticare una ginnastica intellettuale che mira a sviluppare e a controllare le nostre elaborazioni mentali. Bisogna “acquistare un’arte di pensare”.
Gennaio 2022