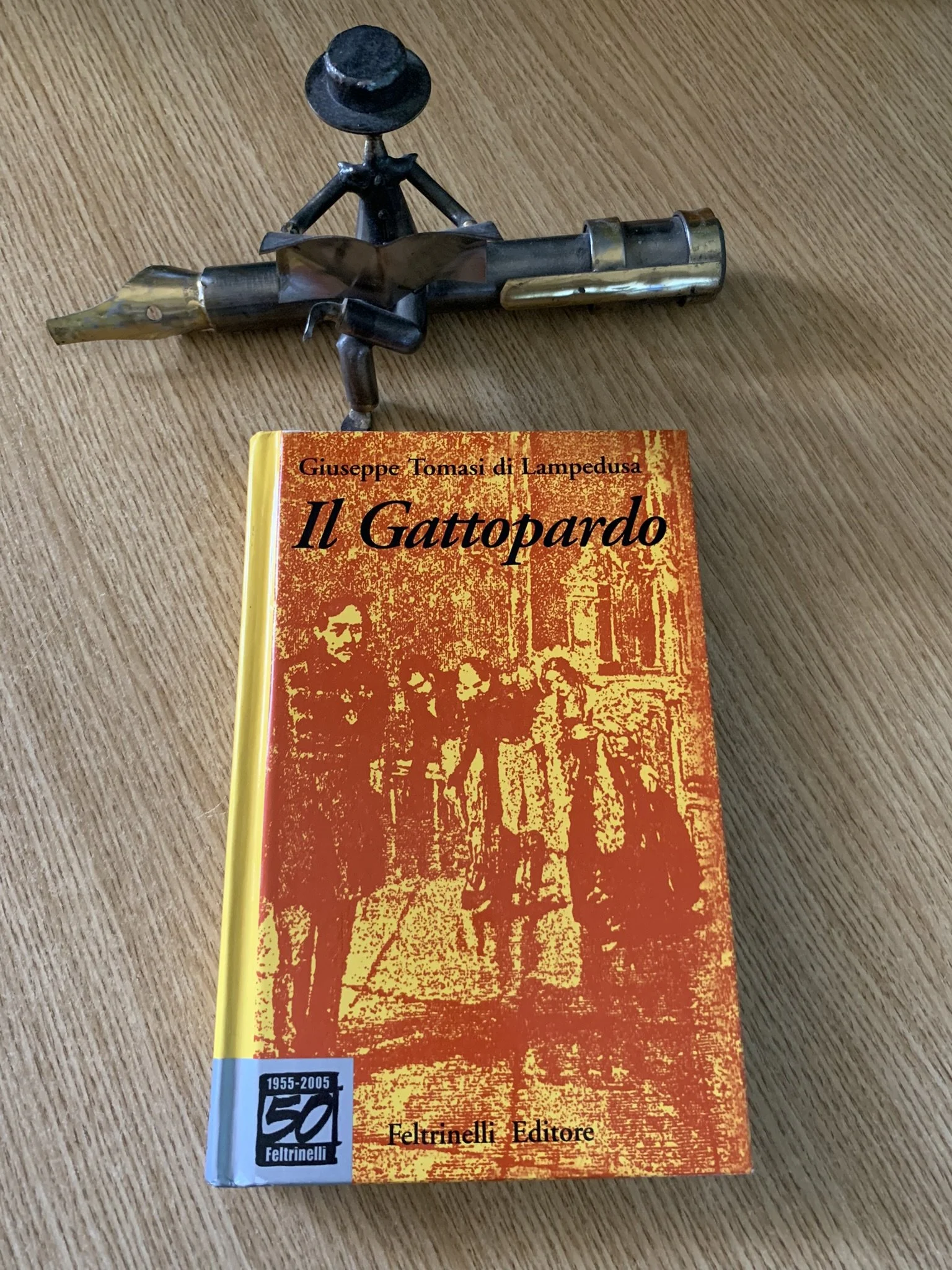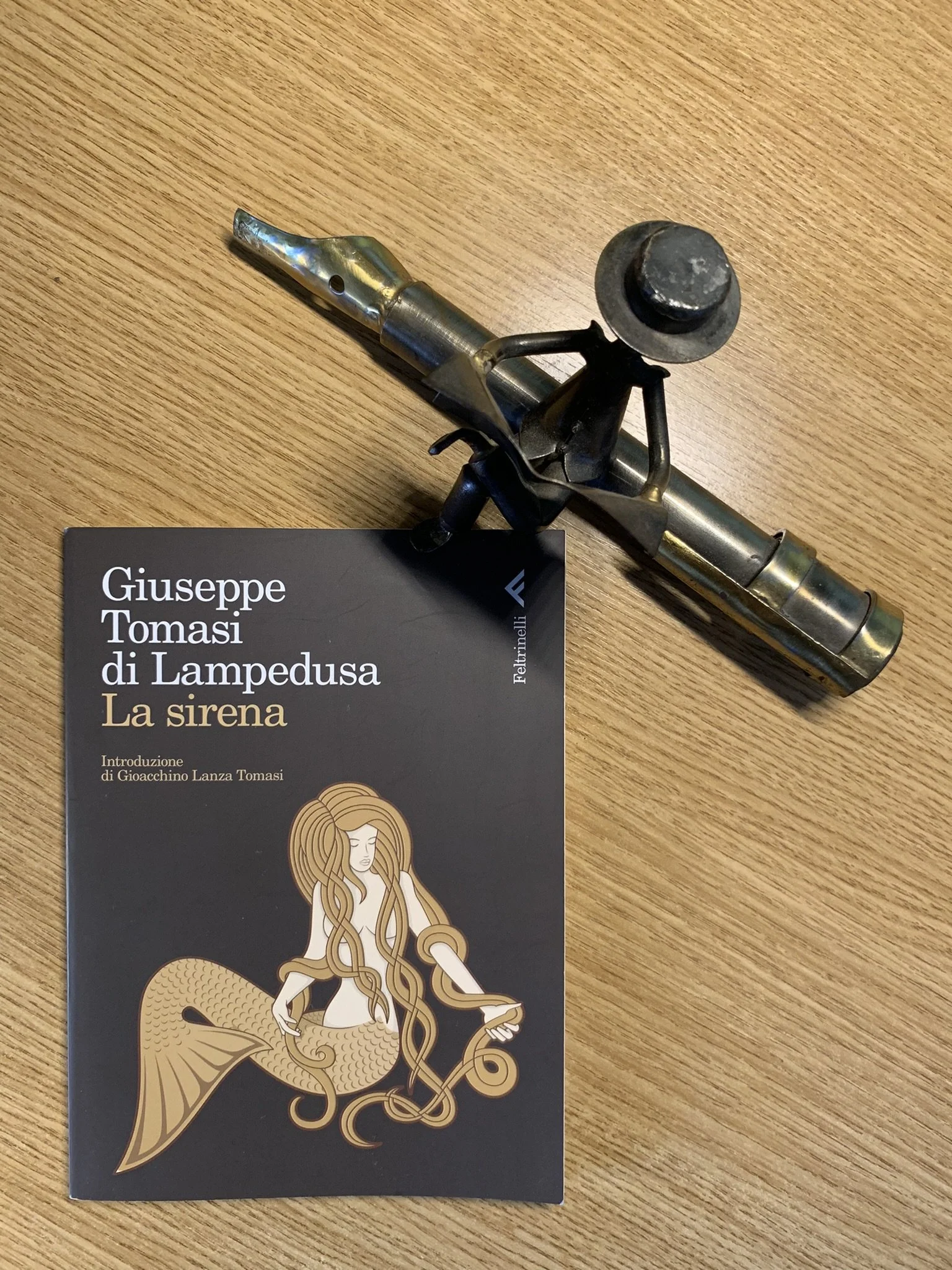È ora di sirena! Parte 1
Intorno a me l’aria estiva divampa; sono alla ricerca di frescura. Siamo a metà luglio e quest’estate non andrò al mare; tuttavia, le calde giornate, la loro luminosità, il frinire ostinato delle cicale mi riportano spesso sulla sabbia bionda della Corsica e della Sardegna. Ricordo e sogno. Sento il bisogno di una vacanza al mare; rimpiango le mie belle nuotate nel Mediterraneo? È molto probabile. Quando il corpo non si sposta, ci pensa la mente. Per trasportarci altrove attingiamo naturalmente al nostro vissuto, a frammenti delle nostre esperienze passate. Però, come risulta assai più efficace lasciarsi incantare dalle immagini che sgorgano dalla penna di talentuosi scrittori! Chissà se un po’ di refrigerio me lo guadagnerò tufandomi a capofitto nel mondo acquatico delle sirene!
I/ MARE DELLA SICILIA
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo
La lettura de Il Gattopardo mi apre il sipario su un paesaggio flagellato dal sole, ansimante e disidratato, sul paesaggio arido dell’isola più grande del Mediterraneo dove finora non ho messo piede. Sto parlando della Trinacria di Omero, della Sicania di Tucidide o, per chiamarla con il suo nome attuale, della Sicilia di Tomasi di Lampedusa (1896 – 1957).
“Si erano attraversati paesi dipinti in azzurrino tenero, stralunati; su ponti di magnificenza bizzarra si erano valicate fiumare integralmente asciutte; si erano costeggiati disperati dirupi che saggine e ginestre non riuscivano a consolare. Mai un albero, mai una goccia d’acqua: sole e polverone…Intorno ondeggiava la campagna funerea, gialla di stoppie, nera di restucce bruciate; il lamento delle cicale riempiva il cielo; era come il rantolo della Sicilia arsa che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia.”
Oltre ad evocare gli avvenimenti storici consecutivi allo sbarco dei Mille a Marsala l’11 maggio 1860, a dipingere il Plebiscito del 21 ottobre dello stesso anno, a ricordare la Giornata dell’Aspromonte di agosto 1862 e soprattutto, a svelare le meditazioni dolorose, i pensieri sagaci, ironici e voluttuosi del protagonista don Fabrizio Corbèra Principe di Salina, lo stile icastico di Giuseppe Tomasi di Lampedusa che infonde vita alle cose inanimate e tramuta i sentimenti in personaggi, acutizza gli effluvi e le forme di una terra enigmatica e trasognata, indolente e sensuale, sorda ai cambiamenti e ancorata alla tradizione, impietosa e superba.
La Sicilia selvaggia e immutabile che, dai tempi remoti dei Fenici, dei Dori e degli Ioni, continua ad essere terreno di gioco del vento insolente e non smette di esalare l’aromatico profumo della macchia mediterranea: “…lo stesso indifferente vento senza soste, marino, muoveva i mirti e le ginestre, spandeva l’odore del timo.”
La Sicilia dalle forme sinuose che paiono imbalsamate: “In cima al monte, di fra i tamerici e i sugheri radi riapparve l’aspetto della vera Sicilia… L’aspetto di una aridità ondulante all’infinito in groppe sopra groppe, sconfortate e irrazionali, delle quali la mente non poteva afferrare le linee principali, concepite in un momento delirante della creazione: un mare che si fosse ad un tratto pietrificato nell’attimo in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde.”
E se i rilievi terrestri sembrano un mare in burrasca impietrito, dall’alto la distesa marina pare cristallizzata: “Oltre le colline, da una parte, la macchia indaco del mare, ancor più minerale e infecondo della terra.” I due elementi si fondono in un rapporto inestricabile nel quale la terra assomiglia all’acqua e l’acqua alla terra
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: La sirena o Lighea
È il mare che fa della Sicilia un’isola, un triangolo di terra, una triscele. La Sicilia, terra brutalizzata dal sole, bistrattata dai venti, prigioniera di un’acqua salifera.
Non è casuale se dopo la stesura de Il Gattopardo cominciata alla fine del 1954 e ultimata nel 1956, Tomasi di Lampedusa compone nel gennaio del 1957 La sirena, quest’altro gioiello di letteratura che sarà definito in seguito “racconto perfetto”. Mentre Il Gattopardo si concentra sulla terra trascurando il mare, La sirena sposta l’attenzione sul mare restituendo alla Sicilia la sua componente liquida e salata, al Mediterraneo le sue movenze, il suo magnetismo e tutto lo scintillìo di cui lo adornano i racconti mitologici della Grecia antica.
Uno scrigno di qualche decina di pagine per custodire la confidenza fatta dal vecchio catanese ermetico e scontroso Rosario La Ciura al giovane palermitano Paolo Corbèra. I due conterranei vivono entrambi a Torino. Il senatore La Ciura è un grecista di fama internazionale; Paolo lavora alla Stampa, noto quotidiano della città. L’amicizia tra loro nasce al caffè di via Po dove si vedono per la prima volta un giorno dell’autunno 1938. La confidenza avviene una sera di primavera del 1939. Nell’intimità di casa sua, l’anziano in uno slancio commosso rivela al giovane attonito il segreto della sua esistenza: l’incontro a ventiquattro anni con la sirena Lighea, nel cuore dell’agosto 1887. Benché la relazione sia durata solo una ventina di giorni, gli ha lasciato un sentimento intenso e impareggiabile, mai affievolito col passare del tempo perché, quando il mito s’insinua nella realtà, è come se il divino accarezzasse il mortale e gli regalasse l’incenso delle cose perenni: “Te l’ho già detto, Corbèra: era una bestia ma nel medesimo istante era anche una Immortale ed è peccato che parlando non si possa continuamente esprimere questa sintesi come, con assoluta semplicità, essa la esprimeva nel proprio corpo.” Notiamo che “Corbèra” è anche il cognome di don Fabrizio Principe di Salina. Non si tratta di una semplice omonimia giacché Paolo svela a La Ciura di essere l’unico discendente superstite del casato decaduto dei Salina. Basta questo breve riferimento a un albero genealogico comune per collegare le due opere. Con un filo sottile Tomasi di Lampedusa annoda la terra del Gattopardo al mare della Sirena. Ma di che acqua ci sta parlando? Del Mar Ionio intorno alla piccola penisola di Augusta ubicata nella parte sudorientale della Sicilia.
“In quel golfetto interno, più in su di Punta Izzo, dietro la collina che sovrasta le saline” specifica La Ciura. E all’evocazione del posto che anche lui conosce, Corbèra prosegue la descrizione in tono elogiativo; ne fa una pittura dove non mancano i riferimenti alla Trinacria omerica: “È il più bel posto della Sicilia; per fortuna non ancora scoperto dai dopolavoristi. La costa è selvaggia…completamente deserta, non si vede neppure una casa; il mare è del colore dei pavoni; e proprio di fronte, al di là di queste onde cangianti, sale l’Etna; da nessun altro posto è bello come da lì, calmo, possente, davvero divino. È uno di quei luoghi nei quali si vede un aspetto eterno di quell’isola che tanto scioccamente ha volto le spalle alla sua vocazione che era quella di servir da pascolo per gli armenti del Sole.” La Ciura rimemora infervorito questa terra appartata lambita dal mare dove il sole, dopo aver accantonato la sua rabbia incendiaria, si fa gioielliere: “Il sole, smessa la grinta sua di carnefice, si accontentava di essere un ridente se pur brutale donatore di energie, ed anche un mago che incastonava diamanti mobili in ogni più lieve increspatura del mare.”
La prima impressione che Lighea produce sul giovane Rosario potrebbe essere sintetizzata in questi termini: una sedicenne desiderabile e inquietante, dai grandi occhi verdi e i denti appuntiti, dai capelli biondi e dalla coda di pesce. Ovvio è riduttivo e sarebbe ingiusto appiattire l’accurata e vivida descrizione di Tomasi di Lampedusa che fa sembrare la sirena una creatura pulsante di vita e realmente esistita.
“Quell’adolescente sorrideva, una leggera piega scostava le labbra pallide e lasciava intravedere dentini aguzzi e bianchi, come quelli dei cani…Questo sorriso fu il primo dei sortilegi che agisse su di me rivelandomi paradisi di dimenticate serenità. Dai disordinati capelli color di sole l’acqua del mare colava sugli occhi verdi apertissimi, sui lineamenti d’infantile purezza…Sotto l’inguine, sotto i glutei il suo corpo era quello di un pesce, rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta…Mostrava con tranquilla impudicizia i delicati peluzzi sotto le ascelle, i seni divaricati, il ventre perfetto, da lei saliva quel che ho male chiamato un profumo, un odore magico di mare, di voluttà giovanissima…Parlava e così fui sommerso, dopo quello del sorriso e dell’odore, dal terzo, maggiore sortilegio, quello della voce. Essa era un po’ gutturale, velata, risuonante di armonici innumerevoli; come sfondo alle parole in essa si avvertivano le risacche impigrite dei mari estivi, il fruscio delle ultime spume sulla spiaggia, il passaggio dei venti sulle onde lunari…”
La vista, l’olfatto e l’udito di Rosario rintracciano in Lighea l’impronta inconfondibile del mare: nella sua coda fosforescente di pesce, nell’odore di salsedine e di alghe del suo corpo, nella sua voce un po’ rauca che richiama il gorgoglìo dei frangenti. L’anziano non parla né di canto né di strumenti musicali, ma di voce. “Parlava e così fui sommerso, dopo quello del sorriso e dell’odore, dal terzo, maggiore sortilegio, quello della voce… Il canto delle Sirene, Corbèra, non esiste: la musica cui non si sfugge è quella sola della loro voce”. La Ciura parla anche di greco antico, la lingua che gli ha permesso di comunicare con Lighea, la lingua nella quale è stato scritto l’originario mito delle sirene. Continua…